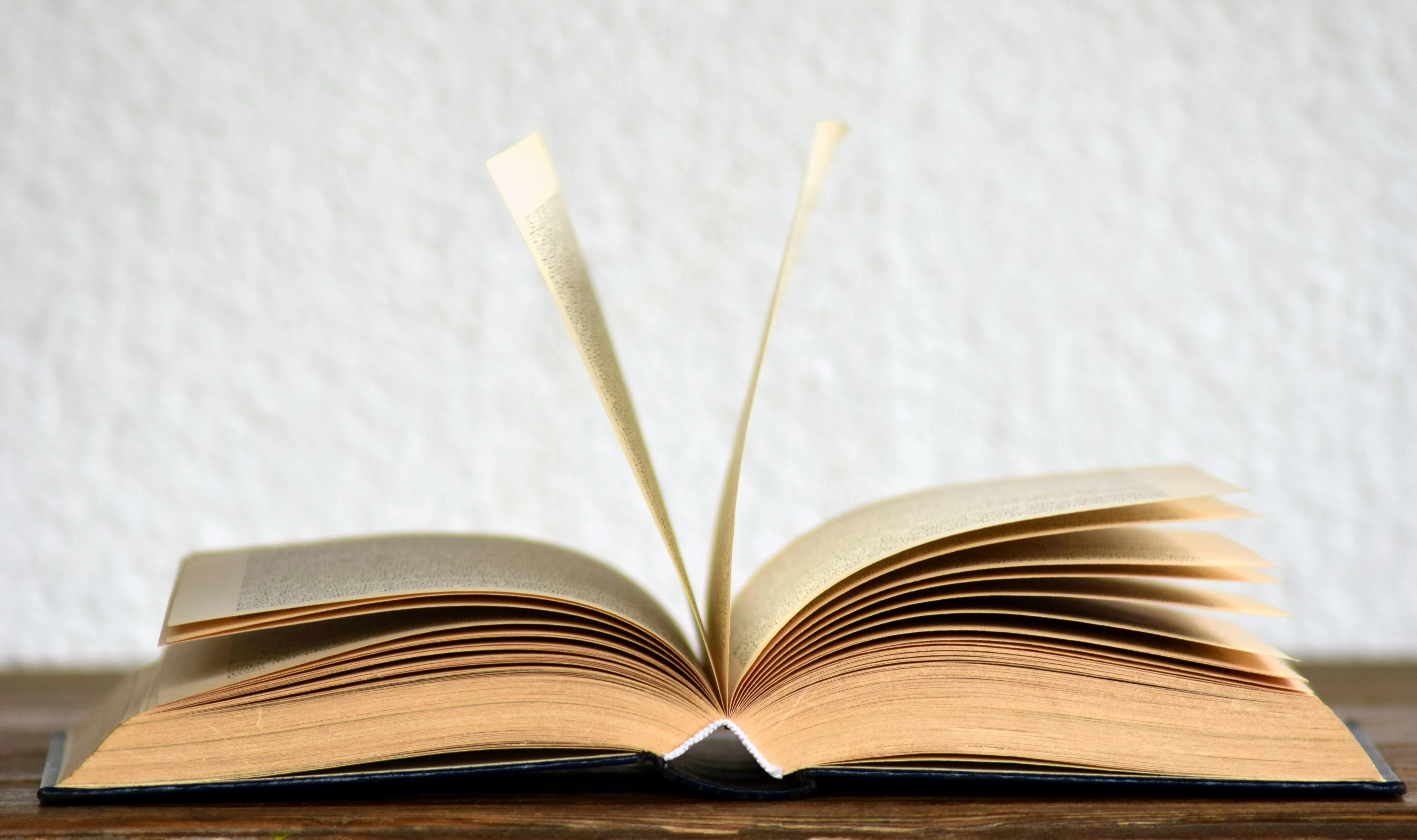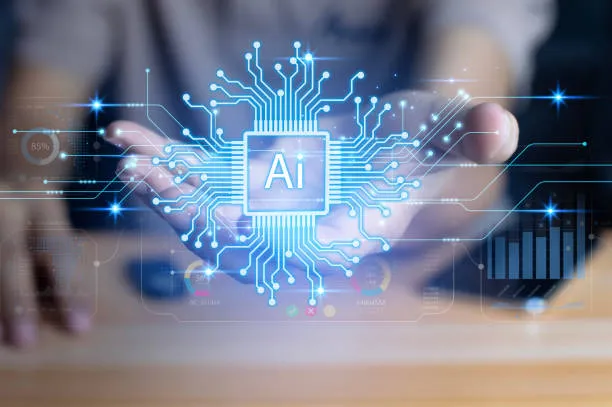Addio ad Antonio Sgamellotti: il chimico che ha unito scienza e arte, svelando i segreti del blu egizio di Raffaello
Indice dei paragrafi
- Introduzione: la scomparsa di Antonio Sgamellotti
- La carriera scientifica di Sgamellotti: riferimento in chimica teorica e inorganica
- L’identificazione del blu egizio negli affreschi di Raffaello
- La ricerca sui beni culturali: scienza e patrimonio italiano
- Il Centro Calcolo Intensivo in Scienze Molecolari: un’eccellenza CNR
- L’impegno accademico e l’eredità all’Università di Perugia
- Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei: un riconoscimento all’eccellenza
- Un approccio pionieristico al dialogo tra scienza e arte
- Tecniche pittoriche storiche: l’importanza dell’indagine scientifica
- L’influenza internazionale di Sgamellotti e i progetti di collaborazione
- L’impatto sulla didattica e sul rapporto studenti-ricerca
- Il ricordo della comunità scientifica e artistica
- Dal laboratorio alle sale dei musei: l’inestimabile valore della diagnostica
- Criticità, sfide e prospettive future nella ricerca su arte e scienza
- Sintesi: l’eredità viva di Antonio Sgamellotti e le prospettive per la ricerca
Introduzione: la scomparsa di Antonio Sgamellotti
Con la morte di Antonio Sgamellotti, avvenuta a Perugia il 22 agosto 2025, si chiude un capitolo fondamentale per la chimica e per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Aveva 86 anni, e il suo nome resterà legato per sempre a intuizioni che hanno rivoluzionato la conoscenza delle tecniche artistiche antiche.
La notizia della morte di Antonio Sgamellotti ha suscitato profonda commozione tanto nel mondo accademico che in quello della ricerca sui beni culturali.
La carriera scientifica di Sgamellotti: riferimento in chimica teorica e inorganica
Le tappe della carriera di Antonio Sgamellotti sono una testimonianza di dedizione alla scienza e all’insegnamento. Per 35 anni ha insegnato Chimica inorganica e teorica all’Università di Perugia, formando generazioni di studenti e ricercatori. Docente rigoroso e innovativo, ha saputo integrare la tradizione della scuola chimico-fisica italiana con una prospettiva interdisciplinare, che lo ha portato a collaborare con esperti di tutto il mondo.
In aula, la sua passione per la materia era pari solo alla sua capacità di stimolare la curiosità.
L’identificazione del blu egizio negli affreschi di Raffaello
Tra i contributi più noti di Sgamellotti figura la scoperta del blu egizio negli affreschi di Raffaello: una scoperta che ha avuto ripercussioni importanti sulla comprensione delle tecniche pittoriche adottate nel Rinascimento. Il blu egizio, pigmento sintetico antico spesso associato all’arte egizia e greca, era ritenuto scomparso dall’uso europeo molto presto.
La scoperta che proprio Raffaello, uno dei Maestri del Rinascimento, lo avesse utilizzato nelle sue opere romane, ha riscritto pagine di storia dell’arte, grazie alle metodologie scientifiche d’avanguardia impiegate da Sgamellotti. La sua capacità di riconoscere la presenza di questo pigmento attraverso indagini spettroscopiche e analisi sofisticate ha aperto scenari inediti sulle competenze chimiche delle botteghe rinascimentali, e su quanto la conoscenza tecnica e quella artistica fossero strettamente intrecciate.
La ricerca sui beni culturali: scienza e patrimonio italiano
Da sempre appassionato di ricerca interdisciplinare, Sgamellotti si era convinto della necessità di unire le competenze chimiche a quelle storiche e artistiche per la comprensione e la conservazione dei beni culturali. Negli anni Novanta, quando questa prospettiva era ancora nuova in Italia, si è fatto promotore di progetti volti all’indagine analitica di dipinti, affreschi, sculture, ceramiche.
Il suo lavoro ha dimostrato come la chimica applicata ai beni culturali non sia solo utile per il restauro, ma sia indispensabile per cogliere i segreti delle tecniche pittoriche storiche e la circolazione dei materiali. La sua pionieristica attività sul campo ha contribuito a formare una generazione di chimici specializzati, oggi impegnati nelle principali istituzioni museali e di ricerca italiane.
Il Centro Calcolo Intensivo in Scienze Molecolari: un’eccellenza CNR
Oltre all’attività di docenza e ricerca, Sgamellotti è stato direttore del Centro “Calcolo Intensivo in Scienze Molecolari” del CNR, istituzione di punta nella simulazione e modellizzazione molecolare. Sotto la sua guida, il Centro è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale e, tra le altre cose, ha sviluppato potenti software per l’analisi computazionale di materiali e sistemi complessi.
Questo impegno ha avuto un impatto notevole anche nella conservazione dei beni culturali, consentendo di ricostruire la struttura e le reazioni di vari materiali pittorici storici, a supporto delle diagnosi tecniche e del restauro.
L’impegno accademico e l’eredità all’Università di Perugia
L’Università di Perugia, dove Antonio Sgamellotti ha insegnato per oltre tre decenni, resta una delle sue eredità più significative. Qui ha formato centinaia di studenti, molti dei quali hanno intrapreso una carriera nella ricerca o nel restauro dei beni culturali. Le sue lezioni univano rigore teorico e passione applicativa: un connubio che resta un modello per chi oggi si avvicina alla chimica delle opere d’arte.
Tra gli insegnamenti più apprezzati figurano le numerose tesi di laurea da lui seguite sull’analisi dei pigmenti antichi e sulla modellizzazione dei siti attivi in materiali compositi. Il suo nome compare su decine di pubblicazioni e articoli condivisi con i suoi allievi, segno di una generosità e di una volontà di trasmettere sapere che si è estesa ben oltre la pensione.
Socio nazionale dell’Accademia dei Lincei: un riconoscimento all’eccellenza
L’appartenenza all’Accademia dei Lincei, in qualità di socio nazionale, rappresentava per Sgamellotti un riconoscimento prestigioso. Si tratta della più antica accademia scientifica italiana, dalla quale sono passati scienziati di fama mondiale. Questo incarico gli ha permesso di influenzare indirizzi scientifici nazionali e di promuovere l’importanza della collaborazione tra scienza di base e altre discipline.
Un approccio pionieristico al dialogo tra scienza e arte
Antonio Sgamellotti è considerato unanimemente un “chimico pioniere della scienza e dell’arte in Italia”. Fu tra i primi a proporre una vera sinergia metodologica tra indagine tecnico-scientifica e studio storico-artistico. L’approccio multidisciplinare ha poi trovato riscontro in numerosi eventi, pubblicazioni, mostre e convegni, ai quali Sgamellotti ha spesso preso parte come relatore.
Non era raro trovarlo, con camice e occhiali, mentre eseguiva prelievi e analisi direttamente nei laboratori di restauro, fianco a fianco con restauratori e storici dell’arte. Fondamentale fu il suo contributo a progetti come “La Scienza per l’Arte”, che hanno fatto storia nel settore.
Tecniche pittoriche storiche: l’importanza dell’indagine scientifica
L’identificazione delle tecniche pittoriche storiche è uno degli ambiti in cui Sgamellotti ha espresso al massimo il suo talento analitico. Oltre allo studio del blu egizio, si è occupato di molti altri pigmenti e materiali: ocre, lacche, rossi di mercurio, e preziose terre coloranti. Le metodologie da lui sviluppate hanno consentito di gettare nuova luce sulla provenienza delle materie prime e sulle reazioni a lungo termine che avvengono nelle pellicole pittoriche.
Spesso, questo lavoro ha permesso di risolvere casi complicati di attribuzione o di restauro, distinguendo interventi autentici da ridipinture o restauri del passato, fornendo così un supporto essenziale a direttori di musei e restauratori.
L’influenza internazionale di Sgamellotti e i progetti di collaborazione
L’attività del professore non si è limitata al solo contesto italiano. Grazie a una rete di rapporti internazionali, ha partecipato a progetti in collaborazione con il Getty Conservation Institute, la National Gallery di Londra, università americane e altri dipartimenti di scienza applicata all’arte in Europa.
Prestigiosi i suoi seminari in Francia e Germania, seguiti da centinaia di allievi. La reputazione di Sgamellotti nel settore del “Calcolo Intensivo in Scienze Molecolari” e nella scienza applicata ai beni culturali ha rappresentato un punto di riferimento anche per team di ricerca stranieri.
L’impatto sulla didattica e sul rapporto studenti-ricerca
Uno degli aspetti più umani di Sgamellotti resta il suo rapporto con gli studenti. Storie personali raccontano di laureandi aiutati ad affrontare difficoltà, del coinvolgimento dei giovani in progetti di ricerca con reali ricadute applicative, dell’incoraggiamento costante a varcare i confini dell’Italia per formarsi all’estero.
Questo legame si riflette oggi nella gratitudine espressa da studenti e colleghi, molti dei quali ancora oggi proseguono nell’analisi delle tecniche pittoriche storiche secondo la scuola da lui fondata.
Il ricordo della comunità scientifica e artistica
A pochi giorni dalla scomparsa, la comunità scientifica italiana si è stretta intorno al ricordo di Antonio Sgamellotti. Numerosi sono i messaggi di cordoglio inviati da enti come il CNR, l’Accademia dei Lincei, l’Università di Perugia, oltre che da realtà museali e fondazioni impegnate nella tutela dei beni culturali.
L’Ordine nazionale dei Chimici lo ha definito “esempio di integrità e innovazione”, mentre molti ricordano anche la sua attenzione per la comunicazione scientifica e il rapporto con il grande pubblico.
Dal laboratorio alle sale dei musei: l’inestimabile valore della diagnostica
Grazie alle sue scoperte, molte collezioni museali, fra cui la Galleria degli Uffizi e i Musei Vaticani, hanno potuto implementare metodologie diagnostiche avanzate a supporto del restauro delle opere d’arte. Non solo il blu egizio di Raffaello, ma anche numerose altre tecniche di pittura murale e su tavola sono oggi meglio conosciute grazie al suo lavoro.
L’applicazione della scienza nei musei, spesso mediata proprio dallo stesso Sgamellotti, ha permesso interventi più rispettosi e mirati, riducendo i rischi di danneggiamento e migliorando la comprensione della storia materiale delle opere.
Criticità, sfide e prospettive future nella ricerca su arte e scienza
La strada tracciata da Sgamellotti non è priva di criticità. Persistono infatti sfide relative:
- Alla scarsità di fondi per la ricerca interdisciplinare
- Alle difficoltà nell’integrazione tra figure di scienziati e storici dell’arte
- All’aggiornamento continuo delle tecniche analitiche, che richiedono formazione specialistica e tecnologie sempre più sofisticate
Queste sfide saranno decisive per il futuro della ricerca applicata alla conservazione dei beni culturali.
Sintesi: l’eredità viva di Antonio Sgamellotti e le prospettive per la ricerca
Con la scomparsa di Antonio Sgamellotti l’Italia perde un pioniere della chimica, ma la sua eredità culturale e scientifica resta viva nelle istituzioni che ha contribuito a far crescere, nei colleghi che ne hanno seguito l’esempio e soprattutto nei giovani studiosi da lui formati.
La scoperta del blu egizio negli affreschi di Raffaello, il dialogo fra scienza e arte, l’innovazione nella diagnostica per i beni culturali, resteranno punti di riferimento fondamentali per la futura ricerca italiana.
Nel ricordo di Sgamellotti, la comunità scientifica è chiamata a proseguire sulla strada dell’integrazione tra discipline, affinché scienza e arte possano ancora una volta svelare, insieme, i segreti più affascinanti del nostro patrimonio.